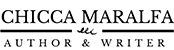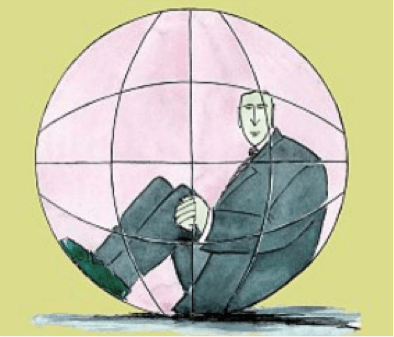Racconto inedito, terzo classificato al premio nazionale “Melina Doti” di Potenza 18 luglio 2021
Chicca Maralfa
Vivo giorni lunghissimi, ma atipici, perché si fanno presto notti. Per la maggior parte del tempo Lea mi siede accanto: siamo in una bolla trasparente, all’interno del nostro mondo di sempre. Io riesco a vederla, lei no, per lei la bolla non esiste, non è cambiato nulla. Per me invece è cambiato tutto, come per gli altri lì fuori. Si lavora molto di immaginazione, è l’unico modo per rendere credibile la propria vita.
Le nostre case sono diventate le nostre città, i nostri paesi, le nostre campagne. Lo spazio come l’abbiamo vissuto fino ad oggi ha smesso di essere tale. Un po’ come il tempo. Sono saltati tutti i confini che conoscevamo e la pandemia ce ne ha imposti di altri. La distanza di sicurezza, che è mentale prima ancora che fisica, è un nuovo tabù. Io direi il nuovo dogma della sopravvivenza.
Lea è seduta sul divano, al solito posto, guarda lontano a qualcosa che non c’è. O forse c’è ma è solo dentro la sua mente. Di fronte a noi, invece, c’è un tavolo da pranzo e dietro il tavolo la finestra della nostra casa in collina. È qui che viviamo da sessant’anni e da qui che si vede il mare.
Una visione che mi appaga e consola. Qualunque sia il mio stato d’animo. Una volta faceva lo stesso effetto su di lei. Oggi, se dovessi chiederle conto, si limiterebbe a fare solo un cenno di approvazione con la testa. Non aggiungerebbe altro, nessuna impressione particolare legata al colore del cielo o del mare, al fatto che ci sia il sole o che sia buio, che il tempo sia bello o brutto. Solo il vento, quando soffia forte, sembra inquietarla. Si alza spesso dal divano e passa da una finestra all’altra quasi volesse fermarlo o montarci sopra.
Il vento è un cavallo:
senti come corre
per il mare, per il cielo.
Vuol portarmi via: senti
come percorre il mondo
per portarmi lontano.
(Pablo Neruda)
Nonostante l’imposto distanziamento, il mondo ci entra in casa con il suo bollettino quotidiano di morti e feriti. La conta giornaliera la chiamo, permettendomi di fare ironia su questo destino improbo. Mi chiedo se gli uomini abbiano peccato di tracotanza, se abbiano sfidato gli dei, desiderando oltre il lecito. Fuori si combatte e qui dentro, nella bolla trasparente della nostra casa, ci si difende. Fermi o facendo qualche passo, il necessario da una stanza all’altra, per sbrigare le ordinarie faccende. I gesti sono limitati da un’ipotetica attesa – ecco, questa è la bolla – anche le emozioni si sono stemperate, acquerellate, sospese, parcheggiate, in attesa di essere raccolte da un angolo di strada per essere condotte chissà dove.
Che ne sarà? Ci saranno restituite, uguali a prima, intense allo stesso modo, riciclate per nuovi usi o dobbiamo dimenticarle, per imparare un altro alfabeto dei sentimenti che la paura del contagio ha reso necessario? Sarebbe come rinascere altrove, con nuovi strumenti, nuovi linguaggi, dimenticando il pregresso per colpa di un progresso che ha perso la bussola, fino a globalizzare le disgrazie e non solo i beni di consumo? Ma soprattutto, quelli come noi, che la maggior parte della loro vita l’hanno già vissuta, faranno ancora in tempo a godere di un abbraccio o del più innocente dei baci?
Ogni sera prima di addormentarmi mi rivolgo queste domande.
Tutto ha finito per apparirci normale solo perché fortemente raccomandato se non sanzionato.
La privazione dell’affetto fisico come regola di prevenzione.
La pelle non può toccare la pelle.
Neanche la più fervida immaginazione d’artista o fantascientifica avrebbe mai potuto ritrarci così lontani eppure così vicini. Genitori, figli, amici, amanti.
Lea c’è, qui con me, anche se ho smesso di abbracciarla.
Ho 75 anni, mi chiamo Marco Settanni, Lea è mia moglie e Alberto Tartari mi ha chiesto di raccontare la mia quarantena. Di scrivere una testimonianza per un settimanale italiano che si chiama Reset.
«Su questo pandemonio mi serve lo sguardo di un vecchio professore di Lettere ». Mi ha detto così al telefono, l’altra sera. Che mica è una fesseria che sono vecchio. Eppure la “vecchiezza” era detta dagli antichi più felice della maturità.
E quindi non me la sono presa affatto a sentirmi chiamare così da lui, che impersona un homo novus di 43 anni non privo di temperanza e moderazione. Tutto quello che ci si dovrebbe aspettare da un uomo oggi: la curiosità e il buon appetito culturale, ma allo stesso tempo la sensibilità e il rispetto per ciò che è stato e non tornerà più. Perché sono quelli come lui a poter tramandare le buone sementi a chi verrà dopo.
Alberto ha la consapevolezza che il passato non debba mai veramente passare, perché non c’è cosa peggiore dello smarrire la memoria. Lo dico a ragion veduta, c’è Lea ogni giorno accanto a me a rafforzare questa convinzione.
Sono molto legato ad Alberto. È stato un mio alunno – il migliore della classe – al Liceo Classico “Marco Polo” di Zora. Correva l’anno 1994 quando si è diplomato e da allora io e lui non ci siamo mai più persi di vista, nonostante la sua vita da inviato speciale: tre anni a Dorothea, quattro a Despina, sette a Fedora, e otto a Zobeide. Fra una e l’altra tappa tanti pericolosi fronti di guerra. Lo mandano lì dove si spara e si muore perché nessuno come lui sa cercare e raccontare persone e cose in mezzo all’inferno.
Una volta l’anno torna al paesello, a trovare me e a portare un fiore sulla tomba dei suoi, che non ci sono più da tempo e pure di sua sorella che se ne è andata l’anno scorso, giovane e bella. Melania dopo aver tanto girato ha chiesto di esser sepolta a Zora, perché “solo lì nella sua immutabilità – ha scritto nelle sue memorie – non ho mai smesso di sentirmi a casa”. Nonostante ci abbia vissuto pochissimo, giusto il tempo di finire le superiori – per poi inseguire i propri sogni a Zobeide, dove ha studiato architettura e messo su famiglia.
Sono io a occupami di tener in ordine la cappella gentilizia della famiglia Tartari, acqua, fiori, preghiere, cose così che si fanno nei cimiteri, e ogni tanto vado pure a dare un’occhiata ai dieci acri di terra che Alberto ha ereditato da suo padre. Si trovano sulla strada provinciale che da Zora conduce a Isidora. Porto Lea con me, se ha voglia di uscire, e lei mi resta accanto mentre parlo con Mimì, il contadino, che è bravissimo, si occupa di tutto e bene, ma ogni tanto bisogna farsi vedere, accertarsi che abbia arato, concimato, insomma fatte tutte le cose che vanno fatte nell’alternanza delle stagioni, per poi raccogliere la frutta che almeno ce la mangiamo noi e lui e non i vermi. Fichi, mandorle, pere e albicocche – Lea fin quando è stata in grado preparava le marmellate per Alberto e per i nostri figli – vecchi alberi che sfornano primizie di un gusto che da tempo non si sente più. Negli anni ho fatto mio il pensiero di Senofonte: temprando il carattere l’agricoltura insegna la giustizia; è nel rapporto con la terra che si rivelano apertamente i buoni e i malvagi – agathoí e kakoí – “la terra infatti non inganna ma schiude generosamente i suoi segreti a chiunque sia davvero desideroso di apprenderli, meglio ripaga chi meglio la tratta”. Non mi pare invece che sia andata allo stesso modo con il progresso che ha bistrattato il mondo, rotto con la tradizione o tutt’al più relegandola all’oleografia, e non ha saputo elevare la modernità a quadro di garanzia delle libere scelte individuali. Oggi la modernità è intesa soprattutto come avanzamento tecnologico – non si poteva compiere errore peggiore. Il nemico è l’obsolescenza e in questa continua rincorsa verso l’ultima trovata da rendere disponibile a tutti per velocizzare i processi – così dicono – si ottiene l’effetto contrario di annullare la vera democrazia dell’accesso, perché aumentano le disparità economiche e i virus come il Covid sono tutt’altro che democratici.
Da quando mi hanno rintanato nella bolla, sento Mimì per telefono e riferisco ad Alberto. A Lea non manca la campagna, non sa neanche cos’è, se non quando la porti lì. La sua vita è fatta di una somma di attimi: quello successivo cancella quello precedente.
A parte darmi affettuosamente del “vecchio professore”, Alberto mi ha eletto inviato speciale sul fronte atipico della pandemia. “Non missili ma microbi. L’ha detto Bill Gates nella sua profezia del 2015. E poi componi il tuo racconto anche con gli occhi di un uomo che non ha mai smesso di essere un ragazzo, innamorato di sua moglie” ha aggiunto, nonostante Lea sia da tempo chiusa nel silenzio di un mondo tutto suo, in cui le parole non hanno più significato. “Il suo silenzioso punto di vista è fondamentale”. Mi ha salutato così.
E io mi sono messo al lavoro.
Ho cominciato a chiedermi quale possa essere il rapporto fra Lea e le emozioni: ne ha ancora? E se sì come sono? Sono le stesse che provo io, è solo che lei non è in grado di esprimerle con le parole? Oppure ha smesso di averne, se non nell’esercizio di un muto bisogno di accudimento, che sono io a interpretare come tale e non lei a richiedere?
Perché noi esseri coscienti – chi più chi meno anche coscienzioso – sappiamo quali sono i ritmi della vita, la sua biologia quotidiana, il cibo e quello che ne consegue, l’igiene personale, la cura dell’intelletto attraverso la lettura e dell’estetica, cui lei teneva tanto perché è stata una bella signora – lo è ancora nonostante l’età – si vestiva bene, aveva gusto, oltre a una classe innata, che non è mai stata esibita, non ha mai raggiunto punte di edonismo, una bellezza semplice e senza fronzoli, e quindi mai autocelebrativa, mai sopra le righe. Mia moglie piaceva per la sua mitezza timida e riservata, per la sua spontanea dolcezza, chi mai avrebbe pensato allora che sarebbe andata a finire così.
Lei ormai non sa, cioè non intende, qualcosa si è rotto nel suo cervello e non si può più riparare. Si può solo cercare di evitare che la macchina si deteriori ancora di più, e consiste in questo l’esercizio della cura. Mia moglie non sa cosa è il passato e men che meno il futuro. Quel futuro ancora più indefinito per “un vecchio professore di Lettere” che è stato un bambino nel dopoguerra e che sa, perché così dice l’orologio della vita, che non ha più tanto tempo davanti a sé rispetto a quanto ne abbia dietro di sé.
In virtù di queste considerazioni mi sono costruito una visione tutta mia degli anni a venire. Del tempo da vivere che ci resta. Nessuna esaltazione, nessuna distopia illusoria, piuttosto una tranquilla prospettiva a breve termine, fatta di un quotidiano “allungato”, edulcorato, giornate cui ho dato una nuova personale dimensione del tempo. Un tempo solo mio e di Lea, i nostri ricordi, il capitale affettivo dei nostri due figli, entrambi lontani, le attenzioni, le mie per lei e le sue per me, seppure quest’ultime scarne, piccoli gesti, talvolta solo una mano stretta sul divano mentre guardiamo la televisione; attività che Lea fa sempre con piacere, anche se non ne parla, non commenta ciò che vede. Io invece le parlo, come se lei potesse capire ciò che dico riguardo a quello che stiamo vedendo, la trama di un film o un documentario sulla natura, perché mai bisogna mollare la nave anche se la burrasca ti colpisce, è necessario restare al comando, senza dare per scontato che debba passare ma neanche immaginarsi già in acqua, aggrappati allo scafo o a una trave di legno.
È stato il virus a mettere in discussione questo sistema, questo equilibrio delle nostre esistenze che non è mai diventato illusione. La pandemia ha gettato il buio in quella fessura di futuro che di giorno in giorno mi andavo costruendo, un mattoncino sull’altro, un pezzettino per volta, perché così si vive alla mia età, non ci si illude più di niente ma un po’ si continua a sognare. Non solo il tempo ha i suoi tempi, diversi da quelli degli altri, ma anche i piaceri hanno altre intensità. Cicerone diceva che li si guarda da lontano, come uno spettatore seduto agli ultimi posti del teatro. Basta la compiutezza di un bel ricordo a tener vive le emozioni, seppure nel distanziamento – parola assai familiare di questi tempi – dai conflitti emotivi. L’anziano gode più a lungo delle cose più piccole, basta una bella giornata di sole a raddrizzargli l’umore, o sapere che un figlio, un nipote o un caro amico andrà a fargli visita la domenica successiva.
Ma poi è arrivato il virus, a eludere tutto questo dalla normalità, a rendere perfino rischiosa l’assistenza che in questa casa entra da fuori, attraverso due volenterose signore, a trasformare la bolla in cui io e Lea viviamo in un vaso fragile, che può andare in frantumi da un momento all’altro. Dovesse toccare a me il contagio, poco male. Ma se dovesse toccare a lei? Lei che riconosce solo questi spazi, questa casa, le stanze in cui si muove da sessant’anni? Come si potrebbe mai spiegarle un isolamento in un altro mondo, senza di me, il suo “caro amico” Marco – così mi chiama – che ogni mattina le prepara la colazione e la sera le rimbocca le coperte prima che si addormenti?
Gianluca, mio figlio, ha trovato il modo per restarci vicino. Ci facciamo le videochiamate, talvolta in quattro perché c’è pure sua sorella Luisa, con o senza le loro famiglie, e così riusciamo a guardarci almeno in faccia. Loro a fine chiamata sembrano soddisfatti, malinconicamente felici, ma tutto ciò che per loro, per i nostri figli, per quelli come Alberto e per le nuove generazioni è normale non lo è per me, che sono abituato a toccare, ad annusare, per sentirmi vero. Se fosse capitata a me la “disgrazia” dell’insegnamento a distanza non sarei stato più io. Anche se quando poi si ì al “fronte”, perché tale è da tempo la scuola, mi sarei rimboccato le maniche per i miei ragazzi, facendo anche l’impossibile.
Mia moglie vive in un’altra dimensione e lì tutto può accadere senza l’aggravio delle domande, dei pensieri sul come e sul dove le cose accadono, anche la paura non sembra riguardarla, anzi non la riguarda affatto. Ci vede girare per casa con la mascherina, vede sua figlia che non sa più essere sua figlia che le sorride in un monitor e le manda baci con la mano, “ti voglio bene mamma – le dice – mi manchi, appena finisce tutto vengo a trovarvi”, e Lea le risponde “grazie, sei tanto cara e gentile”, e in quelle parole vedo scorrere la nostra vita, le loro infinite discussioni davanti ai fornelli, prima di cena fin quando Luisa è stata in casa con noi. Non erano mai d’accordo su nulla, qualsiasi argomento trattassero, Luisa aveva le sue intemperanze caratteriali, perdeva presto la pazienza, era sempre dalla parte opposta rispetto a dove era sua madre, altro che “cara e gentile”, Lea le diceva “sei tremenda” ma poi dopo cena le loro anime si ricomponevano in un abbraccio, le radici si ricordavano di condividere il tronco con la chioma dell’albero e tutto si stemperava nel sonno, per poi ripresentarsi l’indomani allo stesso modo.
Oggi le parla quel po’ che riesce a dire, perché non ha più le parole, non ha più i ricordi, Lea fa tutto ciò che le chiediamo di fare anche se ogni tanto si oppone, si ribella, ma è solo per indolenza. Poco dopo dimentica e se quella stessa cosa gliela chiedi di nuovo finisce per farla, senza opporsi.
Nicola, il mio amico Nicola, se ne è andato l’altro giorno senza il conforto dei suoi figli. Qualche colpetto di tosse, la febbre, il ricovero e poi è morto. Aveva 77 anni e stava bene. Nessuna patologia, mi vado convincendo che è solo questione di fortuna o sfortuna, sopravvivere al Covid o morirne. Zora ha perso una persona perbene che per anni l’ha saputa amministrare da sindaco con la diligenza del buon padre di famiglia. Zora, un paese dove abbiamo imparato a supportare tutto, la fatica, la povertà, la fuga dei giovani ma mai avremmo potuto pensare che questa vecchiaia – che ci rende così universalmente umani – potesse trovarsi a combattere una sfida così impari. Quel po’ di tempo che ci resta dobbiamo viverlo con tutti questi limiti, di libertà, di spostamenti, di contatto fisico con le persone che amiamo.
Le guerre sono tutte diverse eppure tutte uguali quando bruciano una vita ma questa guerra chiamata Covid 19 ci ha spogliato di ogni corazza, ci ha sottratto tutte le armi e mi sembra come una roulette russa con qualcuno sopra di noi che decide se quel proiettile casuale debba colpire Nicola, me o Lea, noi che non abbiamo un orizzonte lungo e quindi neanche uno spazio assicurato in terapia intensiva, se dovesse riempirsi.
Non c’è posto per noi “vecchi” in questa società ipertecnologica e altamente giovanilistica, nonostante la mia giovinezza mentale. Perché sono lucido, non ho acciacchi se non quelli tipici dell’età, ho buona memoria e so di poter dare ancora tanto a chi mi chiede aiuto. Eppure vedo sempre più ristretto il mio spazio di operatività, vado in apnea, mi sento soffocare, perché il lockdown mi ha rinchiuso dentro questi muri, a fare i conti con un fondale buio, in cui mi sento improvvisamente stretto e senza prospettiva. Ci sono giorni in cui mi dimentico perfino di avere il mare oltre la finestra.
Si potrebbe obiettare che alla mia età avere uno spirito così vitale è un alibi con se stessi, che fa finire in secondo piano il decadimento fisico che comunque c’è e avanza, ma io davvero mi sento giovane, pieno di energie, perché ho passato la vita a non disperderle, come invece fanno i ragazzi di oggi distratti da tanti marchingegni nello stesso momento.
Io ho vissuto la mia vita stando sulle cose, nell’hic et nunc, facendo una cosa per volta e questo modus vivendi mi ha consegnato la lucidità che avidamente conservo, perché io sono lucido e lo sono a tal punto da potermi occupare anche di mia moglie nella sua altra dimensione, restando con i piedi per terra nella mia.
Si fa presto a dire saggezza, quasi fosse un paracadute o un salvagente, estrema consolazione della decrepitezza, perché pure se non senti bene o non vedi bene almeno ti si dà del saggio. Che poi, in realtà, mica tutti i vecchi sono saggi. Aver vissuto più a lungo non è garanzia di saggezza, di equilibrio, di buoni valori.
Alla saggezza preferisco l’autorevolezza, che è una dote senza anagrafe, perché è una manifestazione del carattere e non dell’età.
I miei alunni me l’hanno sempre riconosciuta. In casa un po’ meno i miei figli, presi com’erano a rivendicare la propria autonomia in tutti gli ambiti.
Lea se le sorrido mi sorride: è il mio specchio incantato. Mi guardo attraverso i suoi occhi castani, che restano vispi, attenti, talvolta anche pungenti come spilli, non hanno perso l’attenzione quando la sottrai al suo mondo e cerchi di portarla nel tuo.
Nel suo sguardo il virus diventa innocuo, perché smette di fare paura perché lei non ha paura e dunque non devo averne anche io che sono qui per proteggerla. Eppure una paura ce l’ho. L’ho già detto e la ripeto: che il virus possa separarci e io non possa più prendermi cura di lei, vegliare sulla sua incosciente serenità, accertarmi che le signore che si occupano di lei le diano le medicine che deve prendere, all’ora giusta, che provvedano al meglio alla sua igiene personale, che l’assistano durante i pasti, affinché a tavola usi le posate, come ha sempre fatto ma come da qualche tempo ha smesso di fare.
In quest’ultima trincea dove la vita ci ha costretto a stare sempre all’erta, a guardarci da un nemico che può annidarsi dappertutto, posso solo difenderla con l’amore.
Siamo terra di nessuno.